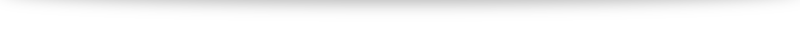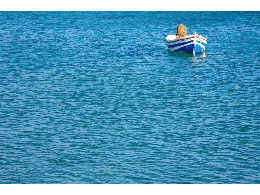Era l’alba e il motore era acceso già, mentre salivamo a bordo. Ci avviammo a prendere posto sulle panchine installate in coperta io, mia madre, mia sorella e gli altri due fratelli, tutti più grandi di me. C’erano già altre persone ed altre ancora ne continuavano ad arrivare.
Era l’alba e il motore era acceso già, mentre salivamo a bordo. Ci avviammo a prendere posto sulle panchine installate in coperta io, mia madre, mia sorella e gli altri due fratelli, tutti più grandi di me. C’erano già altre persone ed altre ancora ne continuavano ad arrivare.
Dopo dieci minuti, non vidi salire più nessuno; il capitano aveva fatto l’appello e ci aveva augurato, in modo sbrigativo, buon viaggio e buona giornata. Pensai che fossimo al completo e che finalmente la grande imbarcazione sarebbe salpata. La passerella, però, non fu ritirata: non si partiva… e non si sapeva perché.
Stavo seduto accanto a mia mamma e guardavo in giro. Anche altri passeggeri erano impazienti.
Fui preso dal rumore sordo del motore; al suo verso “tonc, tonc, tonc…” rispondeva un “tum, tum, tum…” di tutta la struttura in legno, con cadenza ritmata. Mi misi a contare i battiti di quel cuore meccanico e mi fu sempre più difficile tenere aperti gli occhi: abbandonai la testa sull’accogliente spalla di mia madre.
Una ventina di minuti dopo, venni svegliato da un clamore festoso.
Uno sciame di giovani, ragazze e ragazzi traboccanti allegria e contentezza, si era riversato sull’imbarcazione. Erano figlie e figli del padrone del vapore e loro amici… ritardatari di lusso.
Era una domenica dell’agosto del ’47.
Finalmente, fu tirata su l’ancora e sganciata la grossa cima dalla bitta.
Il ‘Filomena Madre’, un grande tre alberi tutto in legno, si staccò lentamente dalla banchina. Sulla superficie calma del mare, oziava sonnecchiante una candida distesa di gabbiani. All’avvicinarsi dell’imbarcazione si dispersero, volando in tutte le direzioni. Li guardai mentre volteggiavano in cielo. Alcuni tornarono a posarsi in mare, altri si misero a scrutarlo dall’alto, in cerca di prede, due o tre si posarono sulla cima degli alberi del veliero e fecero un tratto di mare con noi. Poco dopo, ci salutarono con versi striduli e ci lasciarono. Mi sarebbe piaciuto averli come compagni di viaggio…
Sfilarono le case affacciate sul porto; pescatori mattinieri, sedevano sul molo con le gambe penzoloni, in paziente attesa; sulla lunga passeggiata della marina, si vedeva qualche raro passante a piedi o in bicicletta.
Il peschereccio passò indifferente davanti a quel prodigio che è la fonte Aretusa, dove da millenni una sorgente d’acqua dolce sgorga in una grotta a pochi metri dal mare, raggiunse e si lasciò alle spalle Castello Maniace, che sorge sull’estrema punta di Ortigia.
Calma piatta, non un alito di vento, sul mare galleggiavano le prime luci dorate dell’alba.
Ci allontanavamo, diretti alle tonnare di Capo Passero. Saremmo rientrati in giornata, ma provai ugualmente una dolce malinconia per Siracusa, mentre dietro la sua sagoma s’affacciava il primo sole. Non l’avevo mai vista così. Arrivederci, dissi a quella città che per me, nato altrove, ha sempre rappresentato il mio vero luogo nativo, il primo del quale conservo ricordi.
Seduti sulla coperta e con le teste appoggiate al parapetto, io e mia sorella Franca, di cinque anni più grande di me, guardavamo quell’enorme distesa liquida.
Un marinaio ci passò accanto e, scuotendomi leggermente la testa, con una mano fra i capelli, ci avvertì:
“Stativi attenti ca vi veni ‘u mali di mari! (state attenti al mal di mare!)”
“Ma se il mare è liscio come l’olio!” gli risposi sorridendo. Lo riconobbi: era Zù Janu (Zio Sebastiano), un marinaio che avevo conosciuto nel porto piccolo di Siracusa, e che aveva insegnato a mio fratello più grande come si porta una barchetta a vela latina; spesso ci aveva dato anche preziosi consigli su come affrontare il mare e conoscere il vento.
Avevamo preso il largo e cominciarono ad arrivare le prime folate dell’odore intenso della salsedine, un odore diverso da quello che si sente a riva; sembrava il respiro vigoroso che il mare aperto emana dalle sue profondità. Sentii il mio corpo avvolto da quel profumo forte e selvatico che s’infiltrava nel petto per penetrare fino alle parti più intime dei polmoni. Stetti a lungo a respirare intensamente, fin quasi a stordirmi.
Era la prima volta che mi trovavo in alto mare e stavo vivendo esperienze e sensazioni nuove. Il colore di quella immensa massa liquida adesso era di un blu cobalto intenso, impenetrabile ed inquietante. Pensai che se uno si fosse immerso in quelle acque ne sarebbe uscito dello stesso colore.
I riflessi scintillanti del sole, che si era alzato sull’orizzonte, rimbalzando sul mare, sembravano riversare di continuo luce su luce nel cielo sopra di me che diveniva sempre più luminoso…
Sarebbe stata di sicuro una giornata solare, come il mio animo.
Si levò il vento ed anche la superficie del mare si risvegliò, mostrandosi come un’enorme distesa agitata da onde vigorose ma non minacciose.
Gironzolavo sulla coperta, sorvegliato da lontano da mia madre e dai miei due fratelli più grandi; andai a guardare gli sbaffi che sollevava la prua nel fendere il mare. Le candide ondate di spuma si susseguivano continue e, ricadendo, formavano due scie laterali che sembravano accarezzare le fiancate dell’imbarcazione. Di tanto in tanto, nella nebbiolina che si formava subito al di sopra di quel ventaglio d’acqua, baluginavano frammenti di arcobaleno che rimasi a guardare a lungo, assorto come davanti ad una magia. Rientravo in me quando il vento mi portava spruzzi di mare; allora me ne cospargevo il volto con una mano e ne gustavo il sapore salmastro passandomi la lingua sulle labbra.
Quasi nessuno aveva ancora fatto colazione e l’appetito s’affacciò prepotente. Giunse provvidenziale la distribuzione di panini imbottiti. Agli adulti veniva riempito un bicchiere con vino bianco, ai picciriddri come me venne data una bottiglietta di gazzosa. I marinai facevano la spola tra la cucina e la tolda e non dimenticavano di ricordare ai passeggeri che il ristoro era offerto dal proprietario, del grosso peschereccio e dell’azienda, che aveva offerto anche la gita ai propri dipendenti e ai loro familiari. Pino, il mio fratello più grande, era stato assunto da poco come factotum.
Il panino che ricevetti aveva un profumo delizioso: lo aprii e ci vidi dentro delle fette che non erano della solita scadente mortadella che si comprava a poche lire in quel periodo. Prima d’assaggiarlo chiesi a mia mamma cosa ci fosse dentro.
“Mangia, mangia, e vedi se te ne danno un altro… quello è prosciutto crudo, cibo da ricchi…” disse. Era davvero prosciutto ed era la prima volta che ne sentivo parlare e che ebbi la fortuna di mangiarne. Quel companatico, nel primo dopoguerra, non sapevamo neppure che esistesse.
Il panino era da poco sparito nel mio stomaco, afflitto da fame cronica, quando sentii il comandante che, a voce alta, dava ordini ai marinai. Due di essi liberarono una vela dai legami che l’assicuravano al boma del primo albero, la issarono col paranco e ne fissarono la robusta cima ad un grosso appiglio che seppi, in seguito, avere un nome buffo, galloccia. Vidi il grande telo bianco gonfiarsi al vento, mentre il motore andava calando di giri. La stessa operazione venne ripetuta per le altre vele. Man mano, l’enorme scafo s’inclinava leggermente da un lato mentre le strutture portanti, come gli alberi e le sartie, emettevano degli scricchiolii d’assestamento.
Ora, il ‘Filomena Madre’ era sospinto solo dal vento che faceva sentire la sua voce, in accordo a quella del mare. Insieme, ripetevano la loro antica melodia primordiale, ed io venivo cullato dolcemente in quell’enorme strumento musicale che risuonava, eccitato dallo strisciare sulla massa liquida.
Mi distesi sulla coperta, a prua dell’imbarcazione, con la testa su una cima arrotolata e le mani dietro la nuca. Rimasi, non so per quanto tempo, a godere di quel fruscio naturale, ad osservare lo spettacolo delle vele, piene di vento, sullo sfondo azzurro del cielo, anch’esse in armonia perfetta col resto del veliero che adesso, davvero, sembrava avere un’anima e una vita proprie. Mi sembrò di vivere le stesse emozioni che forse provarono i primi naviganti quando, inventata la vela, affidarono la loro vita al mare ed al vento.
Vedevo solo le grandi vele che fendevano il cielo, in gara con le candide nuvolette che scorrevano all’indietro, e mi parve di volare…
Mia sorella stava parlando con Zu’ Janu, un marinaio di mezza età, lo stesso che ci aveva avvisato di stare attenti al mal di mare. Lei gli aveva chiesto quanto mancava per arrivare a Capo Passero e l’uomo le stava dicendo che, se il vento non avesse cambiato direzione, ci sarebbe voluta ancora circa un’ora e mezza di navigazione. Poi si prodigò a lungo nella spiegazione del rischio di guardare l’orizzonte per chi è propenso al mal di mare. Zu’ Janu era un chiacchierone, e certo non sarebbe stato facile farlo stare zitto, e capii che mia sorella si stava annoiando quando cercò un pretesto per allontanarsi ‘un momentino’.
Rimasi con Zu Janu.
“ A to’ soru ‘un ci piaci parrari ccu i vecchi (a tua sorella non piace palare coi vecchi)” mi disse.
Non risposi. Feci solo una leggera smorfia con la bocca e sollevai le spalle. Lui continuò:
“Quant’anni ci havi (ha)?”
“Quasi diciassette”.
Zu Janu non era vecchio. Avrà avuto più o meno cinquant’anni che però non gli avevano fatto alcuno sconto, e così, egli rispecchiava nel corpo tutto il carico del duro lavoro di pescatore. Sotto la maglietta bianca a mezze maniche, però, traspariva un torace muscoloso. La pelle, abbrustolita dal sole, aveva il colore delle statuine in terracotta del Presepe, colore che, nel volto, faceva risaltare ancora di più il verde profondo degli occhi. Dal berretto di tela blu, della foggia tipica di quelli che portano gli uomini di mare, s’affacciavano capelli rossicci arruffati, già invasi da fili bianchi, al contrario dei folti baffi che mantenevano intatto il loro colore. Sulla fronte e attorno agli occhi, luminosissimi per i riflessi del mare, si affollavano profonde e premature rughe che si accentuavano ancora di più quando acuiva lo sguardo nel guardare lontano. Le sue mani erano un libro aperto: grandi, certamente ancora forti, ma già deformate dall’artrite, mi ricordavano quelle di mio nonno.
A Janu piaceva parlare, ed io non ero da meno in fatto di curiosità. Dopo aver iniziato la navigazione a vela, mi ero accorto che c’eravamo allontanati dalla costa e gliene chiesi il motivo.
“Quannu si va a muturi cumanna l’omu, quannu si va a vela cumanna ‘u ventu, e pi com’ora ‘u ventu è cuntrariu (quando si va a motore, comanda l’uomo, quando si va a vela comanda il vento, e adesso, il vento è contrario)” mi rispose.
“Come si fa ad andare sul mare da un punto ad un altro quando il vento è contrario?”
Disse che era proprio il caso nostro in quel momento e che stavamo navigando ‘di bolina’ ossia ‘bordeggiando’.
Era su per giù come andare a zig-zag ma, anche se lui si era applicato con zelo nella spiegazione, dovetti aspettare molti anni, quando da grande fui proprietario del mio ‘veliero’ di quattro metri, per poter sperimentare e praticare di persona la navigazione di ‘bolina’.
Più tardi, vidi dei ragazzini, su per giù della mia età, ma anche degli adulti, dirigersi svelti verso poppa. Sentii, in mezzo al vociare, che erano apparsi dei delfini e volli andare anch’io. Non avevo mai visto i delfini, se non in fotografia, e lo dissi a Janu, che rimase indifferente davanti a quello che io ritenevo un avvenimento straordinario:
“Di ‘sti parti (da queste parti) ‘u mari è chinu ri (pieno di) delfini” disse semplicemente.
Mi accompagnò a poppa. M’intrufolai fra gli altri curiosi e vidi per la prima volta quegli animali magnifici e divertenti. Un marinaio buttava in mare dei pesci e quelli accorrevano festanti, saltando fuori dall’acqua, emettendo dei suoni che mi sembrarono esprimere, oltre al gradimento per il pasto, anche la loro gioia: sembravano dei ragazzini impegnati in un gioco. Nuotando più veloci della nostra imbarcazione, e sempre rincorrendosi fra loro e saltando, ci affiancarono riscuotendo applausi per la loro esibizione.
Finirono i pesci che l’uomo buttava in mare e finì anche lo spettacolo offerto a ‘pagamento’ dai delfini.
Rimasi a poppa con Janu.
“Perché corrono, saltano e fanno quei versi?” gli chiesi.
“Pirchì sunu filici” mi rispose.
“Che pesci divertenti!” esclamai.
“Parunu (sembrano) pisci ma chiddri ‘un sunu pisci” mi corresse, “i delfini sunu mammiferi”.
Ero rimasto perplesso nell’ascoltare quello che aveva appena detto e mi spiegò che i pesci nascono dalle uova, i delfini invece vengono al mondo come la maggior parte degli esseri terrestri, cani, gatti, l’uomo… Si fermò lì, in rispetto ai miei undici anni, forse pensando che io credessi ancora alla cicogna. Aggiunse solo che ogni tanto i delfini debbono emergere per respirare.
“I delfini si mangiano?” gli chiesi.
Rispose che durante ‘la mattanza’, la pesca dei tonni, qualche delfino capita tra di essi e rimane ferito; allora invece di essere ributtato in mare, dove farebbe un’agonia penosa, viene ucciso subito e spesso anche mangiato.
“Di che sanno i delfini? Voi li avete mangiati?”
Zù Janu tardò a rispondermi. Lo vidi imbarazzato; mi disse di no, ma aveva saputo, da quelli che li avevano mangiati, che sanno di pesce e dal sapore dolciastro:
“Sannu ri pisci… è carni, ma sapi ri pisci…”
“Allora sono pesci!”, dissi, ma lui, scuotendo la testa, concluse:
“I delfini mancianu sempre pisci, accussì, puru iddri sannu ri pisci.”
Rimanemmo zitti un poco. Io guardavo il mare e la costa lontana, una linea appena percettibile all’orizzonte.
Janu mi lasciò assorto in quella contemplazione e si diresse verso prua per mettere un po’ d’ordine. Arrotolò una grossa gomena, la sistemò in una cassa, mise a posto il lembo di una rete che era scivolata sulla tolda, raccolse e lanciò qualcosa in mare. Da poppa, osservavo la lunga scia bianca e ribollente lasciata dal veliero. La percorsi più volte con lo sguardo fino al punto in cui svaniva, confusa tra le onde, e vedevo in essa il segno dell’allontanamento, una strada dritta, come un lunghissimo strumento di misura che, srotolandosi, tracciava la crescente distanza da terra.
Mentre Janu ritornava verso me, notai che mi osservava con uno sguardo che mi sembrò misto di curiosità e tenerezza. Vidi nella sua mente la mia istantanea: piccolo, magro, dalle gambe esili che sbucavano dai pantaloni corti rimediati da mia madre accomodando quelli smessi dai miei fratelli più grandi. Provai pena per me stesso.
L’uomo s’appoggiò di nuovo al parapetto accanto a me. Come avesse intuito quello che pensavo mentre guardavo la scia lasciata dall’imbarcazione, prese a parlare della vita sul mare, della nostalgia della casa e degli affetti più cari, del ricordo di fatti avvenuti poche ore prima sulla terraferma che diventano presto lontani, come se il mare mutasse la dimensione del tempo, delle immagini e delle voci di persone, parenti e amici, che si sbiadiscono subito nella mente ma sono sempre più vicine nel cuore. Ricordi che più si cerca di mettere da parte e più tornano indietro. E soprattutto:
“Sapissi comu ci si senti suli in miezzu a tutta st’acqua (sapessi come ci si sente soli in mezzo a tutta quest’acqua).”
“Sentii crescere la stima per quelli che, combattuti fra amore, rispetto, timore, e spesso, forse, anche odio per il mare, hanno affrontato la sfida e fatto del navigare una scelta di vita.
“Comu fai ri nome, tu?” mi chiese all’improvviso senza voltarsi.
“Antonio” risposi.
“E ‘n casa ti chiamanu Antonio?”
“No, mi chiamano Nino.”
“Ah, Ninu… Ninuzzu!”
“No, Nino.”
“E quant’anni ci hai?”
“Undici”.
Si girò a guardarmi.
“Pari cchiù nicareddru… t’u manciasti ‘u paninu? (sembri più piccolo, te lo sei mangiato il panino?)”
“Certo!” risposi, “hmm…era buonissimo…”
“Tu hai da crisciri, hai da manciari chiù assai (tu devi crescere, devi mangiare di più).”
Abbassai gli occhi:
“Ce ne vorrebbero di panini per farmi crescere…”
Annuì tentennando leggermente la testa; per compassione, pensai. Riprese ad osservare il mare per un po’. Si girò poi di nuovo verso di me:
“Senti ‘n poco, Ninu, ma tu mi capisci quannu iu ti parru (parlo)?”
“Certo che vi capisco.”
“E allura pirchì ‘un parri (non parli ) ‘n sicilianu?”
Ed io sforzandomi di parlare in dialetto:
“Vi cumprendu ma nun ‘u sacciu parlare.”
Janu Sorrise:
“Parra ‘taliano” mi consigliò, “che fai cchiù megghiu… (che fai meglio)”
“Tu ssì ri (sei di) Sarausa?”
“No, sono nato a Tripoli, ma all’inizio della guerra i miei sono rientrati in Italia… i miei, sono siciliani.”
“Tripoli bel suol d’amore…” mormorò Janu, e continuò: “A viri (vedi) ‘sta varca? si chiama
‘Filumena Matri’. Trint’anni arretu, quannu si l’accattò, ‘u mè patruni ci canciò nome e ‘a vosi chiamari commu a so’ matri, ‘Filumena’. Pi’ anni e anni s’annava pì tuttu ‘stu mari a piscari… tanti vote s’arrivava finu a Tripuli, a Tunisi, finu ‘n Maroccu! Tripuli a canusciu comi i ‘me sacchette… (La vedi questa barca? Si chiama ‘Filomena Madre’ Quando il padrone la comprò, le volle cambiare nome e la chiamò ‘Filomena’, come sua madre. Per anni e anni si andava per tutto questo mare a pescare… tante volte s’arrivava fino a Tripoli, Tunisi, fino in Marocco! Tripoli la conosco come le mie tasche!)”
Lo guardai con ammirazione ma invidioso perché conosceva la mia città natale che io non ricordavo per niente, essendo venuto via con i miei all’età di due anni e mezzo. Sperai che non raccontasse frottole…
“Voi sapete parlare l’arabo?” gli chiesi, e aggiunsi orgoglioso: “mio padre l’ha imparato e quando stava a Tripoli faceva anche l’interprete.”
Mi rispose che fino a una quindicina di anni addietro, tutti quelli che viaggiavano per mare, marinai, commercianti, uomini d’affari e così via, parlavano il ‘sabir’ una specie di esperanto risultante dalla mescolanza di varie lingue, italiano (siciliano), arabo, spagnolo, greco e non si incontrava difficoltà a capirsi fra popoli di etnie differenti.
Da un bel po’, avevo notato sul suo braccio sinistro il tatuaggio di una sirena e di un nome: Lucia.
“E’ vero che le sirene sono per metà pesci e per metà femmine?”
Janu forse si pentì di essersi mostrato così disponibile alle chiacchiere che gli avevano messo davanti un ragazzetto tanto curioso. Ci pensò su per un poco, gettò uno sguardo alla ‘sua sirena Lucia’ dipinta sul braccio; al leggero sorriso che ancora appariva sul suo viso si mescolò una lieve ombra di tristezza, mentre tentennava su e giù il capo:
“Chista”, disse indicando con gli occhi il tatuaggio, “chista era ‘a me’ sirena tant’anni arreri e j’era tutta fìmmina, e tutta ri carni; havìa l’età ‘i to’ soru, quannu ni maritammo. Iu havìa venticincu anni e stava sempri pi mari… ‘Nn jornu turnai a casa e ‘un ci ‘a truvai. Si n’havia fujutu e n’a vitti cchiù! (questa era la mia sirena tanti anni addietro, ed era tutta femmina e tutta di carne; aveva l’età di tua sorella, quando ci sposammo. Io avevo venticinque anni e andavo sempre per mare… Un giorno tornai a casa e non ce la trovai. Se n’era fuggita e non la vidi più!)”
Rimasi profondamente mesto e senza parole. Quando m’accorsi che l’alone di tristezza s’era allontanato anche dal suo viso, gli chiesi:
“E’ vero che ci sono marinai che hanno visto le sirene?”
“Quannu si sta pi’ ‘na misata (una mesata) luntanu ‘i casa” rispose, “e si viri (vede) sempri mari, mari, mari e celu, celu e mari… cu’ pensa ‘a mugghieri (moglie) sua, che sta ‘n casa aspittannu a iddru, a sira (sera) si fa cumpagnia cu na buttigghia ‘i vinu; e a picca a picca (a poco a poco), prima s‘a viri (vede) ‘nta fantasia, doppu s’a viri davanti, commu ci fussi vicina… e all’urtimu s’a senti cantàri… Ri sti sireni iu ni vitti tanti… (di queste sirene ne ho viste tante)”
Il sorriso era sparito ed era rimasta una piega amara sul suo volto.
“Allora è tutta una leggenda…” dissi deluso.
“Cu’ ‘u po’ sapìri… iu ‘un ni vitti mai, però ‘i sintii cantari, cchiù di ‘na vota ( Chi può saperlo… io non le ho viste mai, però le ho sentite cantare, più d’una volta).”
“Rais!” chiamò un marinaio.
“Nni virimu (vediamo) dopu”, disse Janu alzandosi dalla panchina dove intanto c’eravamo seduti, “m’avissi piaciutu ‘i crisciri ‘n picciriddru com’a tia! (mi sarebbe piaciuto crescere un ragazzino come te!)”
Lo guardai, finché non scomparve dalla mia vista, mentre si avviava, un po’ curvo e zoppicando leggermente. I calzoni, rimboccati fino ai ginocchi, lasciavano scoperta nella gamba destra una cicatrice, rattoppata malamente, che partendo da dietro al ginocchio arrivava alla caviglia, dopo avergli devastato il polpaccio: la sua figura, combaciava con quello che ero riuscito a leggere del suo animo.
Mi alzai anch’io e gironzolai, curiosando un po’ intorno. Avevo notato che Janu, a bordo, non aveva alcuna mansione. Mi avvicinai ad un marinaio che in quel momento stava tirando dell’acqua dal mare con un secchio. Gli stetti accanto in silenzio per un poco; quando s’accorse di me, gli chiesi:
“Perché a Zu Janu l’anno chiamato ‘Rais’ e che fa sul peschereccio?”
L’uomo svuotò il secchio spargendo l’acqua sulla coperta per risciacquarla.
“’U sai chi ssì curiusu… (lo sai che sei curioso?) quant’anni ci hai?” mi domandò. Quel giorno era la seconda volta che mi veniva chiesta l’età. Non sapevo se rispondergli; sapevo di essere di statura più bassa per i miei undici anni, cosa che fu il mio tormentone nell’adolescenza… mentii:
“Ho nove anni.” Il marinaio mi scrutò dall’alto in basso, mi fissò a lungo in volto, socchiudendo gli occhi:
“Quannu cc’è ‘a mattanza ri tonni ‘u Rais è ‘u capu ri tutti i piscaturi, chiddru chi havi granni spirienza e cumanna; ma Zu Janu ‘un fu mai Rais”.
(Quando c’è la mattanza dei tonni ‘il Rais’ è il capo di tutti i pescatori, quello che ha grande esperienza e comanda; ma Zio Jano non fù mai Rais)
“Allora, perché l’ho sentito chiamare così?”
Raccontò che, tanti anni addietro, durante una mattanza di tonni, Janu scivolò e cadde nella grande rete rischiando di morire in mezzo ai grossi pesci che, terrorizzati per la loro fine imminente, si agitavano sballottandolo a colpi di coda. Egli cercò più volte di afferrare le mani che gli allungavano i suoi compagni ma perdeva sempre la presa; in ultimo rimase agganciato casualmente da un rampone alla gamba destra, e “piscatu comu ‘n pisci.”
Janu ebbe salva la vita ma rimase mezzo invalido per sempre. Fu promosso ‘Rais’ in riconoscimento del suo sacrificio. ‘Ad honorem’ si direbbe oggi.
“Tu ssì nicareddu (piccoletto)” disse allungando un braccio e con la mano tesa ad indicare la mia statura, “ma mi sapi (sa) che ci hai chiù assai (più) ri novi anni” concluse allontanandosi.
Riguardai in mente mia Zu Janu: pensai che la sorte finora non era stata generosa con lui. Sperai che il futuro gli riservasse una vecchiaia serena. Gli volli bene.
Raggiunsi mia madre e mia sorella e mi misi a parlare con loro accennando a quello che mi aveva raccontato Zù Janu. Poco dopo mi sentii chiamare:
“Nino… Ninuzzu!”
Da una finestrella della cabina dei comandi, un uomo mi faceva cenno di avvicinarmi. Quando fui sotto, m’invitò:
“Acchiana, veni supra!” Era il capitano, quello che ci aveva augurato buon viaggio prima di partire. Rispose al mio saluto con un breve sorriso: anch’egli, come il marinaio di poco prima, mi gettò uno sguardo rapido ma intenso, come volesse stamparsi in mente la mia figura. Sperai di non essere sottoposto ancora alla tortura di dire la mia età.
Salii i gradini della scaletta in legno e mi trovai in un locale non molto grande, sopraelevato e panoramico. Zù Janu stava, orgoglioso, al timone. Il capitano ne ricamò le lodi, dicendo che lui conosceva benissimo quel tratto di mare, insidioso per i numerosi scogli nascosti, e per questo gli aveva affidato la guida del ‘Filomena’.
Janu mi guardò di sottecchi, cercando di nascondere un sorriso sotto i baffi:
“Ti piacissi (ti piacerebbe) ‘i purtari ‘sta varca?” mi chiese, “Mittiti avanti a mia!” Capii la sua intenzione.
“Forza, teni tu ‘u timuni!” Passai sotto un suo braccio e mi trovai davanti la grande ruota. A malapena arrivavo a vedere la prua. Non sapevo che fare; Janu mi prese una mano e la portò su una maniglia, e ugualmente fece con l’altra.
“Strincili forti! Viri (vedi) com’è facili?” Tolse le sue mani dalla ruota: sentii la forza del grande veliero prevalere su quella delle mie deboli braccia di ragazzo e capii che non era un gioco. Janu mi concesse per qualche minuto l’illusione di essere io il timoniere, poi disse:
“Ora veni u trattu cchiù difficile”. Capii che dovevo farmi da parte.
Su un ripiano avevo visto una bagnarola piena di uva zibibbo in ghiaccio e, a lato, un vassoio con ancora dei panini ripieni. Il mio interesse per quel ben di Dio non dovette sfuggirgli. Non feci in tempo a sperare che mi venisse offerto di mangiarne, che gli sentii dire, rivolto al capitano:
“Chi rici, ci ‘u ramu ‘n paninu e ‘n’anticchia ‘i racìna a ‘stu picciriddru? (Che dici, glielo diamo in panino e un po’ d’uva a questa ragazzino?)”
“Sì pensi ca s‘u merita…” rispose sornione l’altro.
Accettai di buon grado quel panino ‘da ricchi’ e lo zibibbo squisito.
Mi sentivo osservato e cercai di mangiare lentamente, per nascondere la mia voracità.
Stavo piluccando felice l’uva, quando ci giunse una folata di voci giovanili, accompagnata dal rumore di un calpestio veloce sulla coperta. Guardando attraverso i finestrini vedemmo tanti corpi in costume da bagno, ragazzi e ragazze, di una nudità, quest’ultime, che mai avevo visto tanto spinta, neppure sbirciando di nascosto nelle riviste femminili che leggeva mia sorella.
A Zù Janu non sfuggì la mia meraviglia e l’interessamento per quello spettacolo:
“’I viristi ‘i sirene’…ah?”
Annuii mentre, arrossito in volto, sorridevo impacciato. Le ragazze esibivano i loro corpi protette soltanto da un ardito due pezzi, l’antenato del bikini, che, introdotto soltanto un anno prima, soltanto le più ‘svergognate’ osavano indossare.
Rivolsi la mia attenzione, allora, alla costa che era già vicina. Guardai la terraferma, pianeggiante e arida. A meno di un chilometro, un isolotto sembrava attaccato ad essa.
“Tra ‘na decina ‘i minuti arrivamu”, disse Janu, “chiddra è ‘l’Isola delle Correnti’. Ora ti fazzu vìriri unni (ti faccio vedere dove) cantavanu ‘i sirene”.
Raccontò che fino ad una trentina d’anni addietro, nelle giornate di tempesta, si sentiva il canto delle sirene provenire da essa. I marinai erano atterriti da quel sibilo che mutava sonorità, a seconda della direzione e della intensità del vento: una risata trista quando spirava la tramontana, un lamento col libeccio, un’invocazione amorosa con lo scirocco.
Alcuni, quando sostavano nell’isolotto per eseguire dei lavori di manutenzione alle loro attrezzature, e venivano sorpresi dal cattivo tempo, avevano individuato che quella specie di canto proveniva da un antica torre di guardia, per l’avvistamento dei pirati saraceni, allora ridotta ad un alto scheletro pieno di fessure tra i massi e le pietre. Nessuno osava avvicinarsi ad essa o addentrarvisi:
“Iu puri ‘u sentia ddru cantu e tutti ‘i voti mi si rizzavanu i pili ri vrazzi… ma era ‘n carusu ri quinnici anni… (Io pure l’ho sentito quel canto e tutte le volte mi si rizzavano i peli delle braccia, ma ero un ragazzo di quindici anni…)”
Ascoltavo con apprensione e col fiato sospeso quel racconto che mi coinvolgeva nel mistero.
“Adesso non si sente più quel canto?” chiesi.
“’Nun si senti cchiù pirchì ‘na scossa ri terrimotu fici carìri tutti cosi.”
Proseguì dicendo che i più fanatici erano persuasi che le sirene erano rimaste sotto le macerie e a chi, scettico, gli chiedeva come mai non erano stati trovati i loro corpi, spiegavano che quelle erano spiriti di antiche divinità pagane che, sicuramente, s’erano trasferite altrove.
La credenza resistette anche alla spiegazione che illustri studiosi avevano dato di quel fenomeno che si verificava perché il vento, filtrando attraverso delle fessure nei muri, si comportava come il soffio di un suonatore nel flauto.
Ripresi fiato, confortato da quella spiegazione.
Sentii il motore che entrava in funzione e vidi che i marinai ammainavano le vele.
Passammo a poca distanza dall’isola. Era disabitata, date le sue modeste dimensioni. C’erano solo casuzze, delle casupole basse, una appresso all’altra, che i pescatori adibivano a magazzini per le reti e per tutti gli altri attrezzi da pesca.
Il ‘Filomena Madre’ gettò le ancore a circa duecento metri dalla costa, per evitare gli scogli affioranti. Furono calate in mare delle barche per portare a terra i passeggeri. Janu mi indicò quella su cui prendere posto con i miei perché l’avrebbe portata lui con un suo collega. Scese per ultimo sulla barca. Poco prima l’avevo visto chinarsi sulla tolda e baciarla. Non capii perché.
Mentre ci dirigevamo verso terra, uno dei passeggeri della barca, indicando con la mano il peschereccio, disse:
“Taliate (guardate)!”
Tutti ci girammo a guardare. I giovani ‘allegri e spensierati’, saliti sul parapetto, si tuffavano per raggiungere a nuoto la riva. Le ragazze, più spavalde e più esibizioniste, per avere un trampolino ancora più alto, sfruttando la generosità dei marinai rimasti a bordo, salivano sulle loro spalle e si gettavano giù a capofitto in mare.
Scesi a terra, la prima cosa che mi colpì e che tutti avvertirono, fu l’intenso odore di pesce bollito che riempiva l’aria. All’interno del laboratorio stavano bollendo i tonni che poi, a lavorazione ultimata, sarebbero stati messi in scatola.
In attesa del pranzo, trascorremmo un’ora circa in quel mare limpido ed incontaminato, dando sfogo a tutta la nostra vitalità giovanile. Ci tuffammo, nuotammo, facemmo pure delle gare fra noi e raccogliemmo tanti frutti di mare, granchi, cozze e ricci saporitissimi.
Alla mezza suonò una campanella e capimmo tutti, con piacere, che era l’ora del pasto. Faceva molto caldo, c’erano pochissimi alberi e, per proteggerci dal sole, avevano approntato una lunghissima tavolata sotto un pergolato d’uva, che continuava in una lunga tettoia fatta di canne intrecciate, sorrette da pali di legno. Ci fu servito un primo di tagliatelle condite, manco a dirlo, con un ragù di tonno, poi fritto misto di pesce, vino, acqua di seltz, tanta frutta e qualche dolcetto di pasta reale.
Zù Janu si prodigava, assieme a donne del luogo, a portarci le vivande e, ogni volta che mi passava vicino mi salutava con un leggero scappellotto, fingendo poi di non essere stato lui. In uno di questi passaggi io, aspettandomi il solito ‘saluto’, chinai la testa e la sua mano raggiunse mia sorella che mi sedeva accanto. Imbarazzato, Janu le s’avvicinò mormorando:
“Mi scusassi, signorina, sbagghiai birsagghiu, era pi iddru!” e indicandomi sottolineava il rimprovero con uno sguardo che voleva sembrare severo.
Nel pomeriggio visitammo le strutture della tonnara: gli enormi pentoloni dove bollivano i tonni, il reparto per la conservazione e tutto il resto che, in vero trovai noioso e opprimente, anche per il forte odore di pesce cotto che arrivava in ogni angolo.
Indimenticabile fu invece la visita a quel luogo, selvatico e affascinante dove, in mezzo ad una vegetazione rigogliosa, si potevano scorgere torrenti e laghetti frequentati da uccelli acquatici di tutte le specie, un paradiso che in seguito sarebbe diventato ‘l’Oasi di Vindìcari’.
Il Filomena madre, all’ancora, sembrava aspettarci pazientemente per riportarci a Siracusa. Ondeggiava tranquillo cullato dal mare che adesso, come succede di solito al pomeriggio nella costa sud-orientale dell’isola, si era fatto più vivace. Assieme ai miei fratelli e ad alcuni loro amici, guardavamo la grande imbarcazione, e io immaginai i viaggi avventurosi che nella sua lunga vita aveva affrontato.
Lo sguardo dei ragazzi andò sulle barche che ci avevano portato a terra e che oziavano legate al molo.
“Chi se la sente di prenderne una e raggiungere il peschereccio?” disse uno di loro in tono di sfida. Da incoscienti, in sei o sette, tra i quali i miei fratelli, accettarono entusiasti la proposta, salirono su una barca ed io con loro. In quel momento, il mare non era più tranquillo come prima; quello era pur sempre il mare del Capo delle correnti e fece onore al suo nome. La barca prese ad allontanarsi dalla riva trasportata più dalla corrente che dalla spinta dei remi dei ragazzi inesperti, i quali tentarono invano di dirigersi verso il grosso peschereccio venendo trascinati, invece, in tutt’altra direzione.
In due si misero a remare di gran lena ma ci allontanavamo sia da terra che dal peschereccio. Ci fu tutto un vociare di consigli ed esortazioni che crearono del panico. Si ruppe per sfortuna pure uno stroppo, l’anello di corda che tiene il remo legato allo scalmo. Si cercò di rimediare con una cintura, ma quella, fatta di cuoio autarchico, poco più che cartone, resistette solo per pochi secondi e si ruppe anch’essa. Il remo cadde in acqua e questo segnò la resa al potere del mare.
Guardai quel legno prezioso che s’allontanava veloce dalla barca portandosi appresso la speranza di far ritorno a riva. Fu deciso allora di legare una camicia bianca all’altro remo col quale, agitandolo disperatamente e senza dignità, i nostri eroi chiesero aiuto.
Da terra, per fortuna, si accorsero delle nostre difficoltà e due marinai ci raggiunsero con un’altra barca.
Quando ci furono a fianco, mi accorsi con piacere, che uno dei due era Zù Janu.
“Figghi di butt…” gli scappò di bocca per la rabbia, “vulissi sapiri cu fici ‘sta biddra pinsata! Pure ‘n remu si persero ‘n mare. Si ‘u ripescu, ‘n testa ci ‘u rumpu … e si purtaru puri ‘u picciriddru… ‘a currenti in Africa vi purtava …” e rivolto a me: “nenti nenti ci ‘u ricisti tu ca vulivi vìriri Tripuli… ah?”
“(Figli di putt… vorrei sapere chi ha fatto questa bella pensata! Pure un remo si sono persi in mare. Se riesco a trovarlo in testa glielo rompo … e si sono portati pure il ragazzino… la corrente vi portava in Africa! Per caso gliel’hai detto tu di voler vedere Tripoli?”)
Incazzatissimi, ci rimorchiarono a terra.
Al tramonto ci preparammo tutti per il ritorno; io provavo già nostalgia per quel luogo.
Mentre prendevamo posto nelle barche che ci avrebbero portati sul ‘Filomena Madre’, vidi Zù Janu che, da terra, mi guardava e agitava una mano per salutarmi.
“Voi non tornate con noi?” gli chiesi a voce alta.
“Nonsi” rispose, “iu mi staiu ‘ccà (io rimango qua).”
Ebbi una fitta dentro di me, mi venne quasi da piangere. La barca era ancora ferma, in attesa di riempirsi e ne approfittai per ridiscendere a terra.
Raggiunsi Zù Janu:
“Pirchì vui ‘un vinite cu nuiautri?” gli chiesi con le lacrime che ora non riuscivo più a trattenere.
“Vedo che hai imparato a parlare in siciliano in un giorno” mi disse con un mesto sorriso sulle labbra.
“E vui a parlare ‘taliano. Quannu arriturnate a Sarausa e ci virimu novamenti?”
“Chi lo può sapere, io vivo a Capo Passero”.
“Tiniti ‘a famigghia ccà?”
“Mah… vivo solo… con mia madre vecchia… e questo è stato il mio ultimo viaggio, per il ritorno. Fra qualche giorno il ‘Filomena Madre’ sarà venduto o demolito…”
Mi sentii demolire io, dentro. Capii il significato del bacio dato al ‘Filomena’ e la tenerezza verso di me. Quel giorno era nato un affetto reciproco, destinato a sopravvivere soltanto nel ricordo. Oramai piangevo a dirotto; gli porsi la mano per salutarlo. Sentii la sua, grande, forte e nocchieruta che stringeva la mia; poi egli mi avvicinò a sé e scomparvi nel suo abbraccio vigoroso.
Sentii scricchiolarmi il torace, mentre, dai suoi sussulti, capivo che anche lui era commosso. Sentii l’odore pungente del suo corpo, che sapeva di mare e di fatica, e che ricordai per tanto tempo, quando pensavo a lui.
Mi sciolsi dal suo abbraccio e, guardando a terra, mi accinsi ad avviarmi verso la barca.
“Aspettami qui un momento”, mi disse.
Ritornò, quasi subito, portando una bella e grande conchiglia a spirale. Me l’accostò ad un orecchio coprendomi l’altro con una mano:
“Senti?” mi chiese.
“E’ ‘a vuci r’u mari”(E’ la voce del mare) dissi.
“E’ la voce di questo mare! Tutte le volte che l’ascolterai, sono sicuro che ricorderai Capo Passero e questa giornata”.
“M’arricorderò pi’ sempri pure ri vui” mormorai, “grazie”.
Lo guardai in faccia, per l’ultima volta. Attraverso il velo di lacrime che mi ricopriva gli occhi, la sua figura appariva deformata e tremolante.
“Nni virimu (Ci vediamo)” dissi, come una promessa.
“Speriamo presto! Chi lo può sapere!?”
Il viaggio di ritorno non fu allegro e pieno di aspettative come all’andata. Venne presto sera e poi notte. Mi sembrava di viaggiare nell’inchiostro. Non c’era neppure un po’ di luna.
Dov’era tutto quel sole della mattina?
I giovani ‘allegri e spensierati’ avevano smesso la baldanza del giorno appena trascorso. Sistematisi a poppa, avevano preso a cantare, sulle note malinconiche di una chitarra che riproponeva il motivo ricorrente quell’anno, cantato da Rita Hayworth nel film ‘Gilda’.
Una ragazza intonò un ‘Amado mio’ che mi seppellì nella tristezza.
Antonio Piazza
San Benedetto del Tronto
Il racconto “L’ultimo viaggio del ‘Filomena Madre’” ha partecipato all’edizione 2012 del Premio Letterario “Vincenzo Licata – Città di Sciacca”, classificandosi al SECONDO POSTO della sezione “Racconti a tema libero in italiano”.