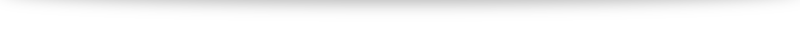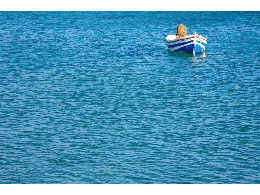Non mi accorsi di quell’uomo fino a quando non riattraversai la strada, guardando istintivamente prima a sinistra e poi a destra com’ero abituato a fare nel traffico della città. Inutile precauzione del momento che la strada era deserta; non c’erano automobili né pedoni e nemmeno segnali della loro presenza nelle adiacenze. Se non avessi indossato scarpe con la suola di gomma avrei udito soltanto il rumore dei miei passi.
Non mi accorsi di quell’uomo fino a quando non riattraversai la strada, guardando istintivamente prima a sinistra e poi a destra com’ero abituato a fare nel traffico della città. Inutile precauzione del momento che la strada era deserta; non c’erano automobili né pedoni e nemmeno segnali della loro presenza nelle adiacenze. Se non avessi indossato scarpe con la suola di gomma avrei udito soltanto il rumore dei miei passi.
Strano, perché era da poco passato mezzogiorno e quel luogo si trovava nel pieno centro storico del paese, quindi qualcuno avrebbe dovuto esserci, un venditore ambulante, un pensionato a passeggio in attesa dell’ora di pranzo, una massaia con la borsa della spesa, un bambino che giocava, e invece niente, nemmeno un gatto o un cane, soltanto qualche fruscio di ali provocato dal volo dei colombi da un tetto all’altro.
Avevo attraversato la strada per un motivo piuttosto banale: attaccato al portone del palazzo dei Baroni Tortorici, un cartello sbiadito molestava la facciata in stile gotico della costruzione e il grande portone d’ingresso, polveroso e piuttosto malconcio – sembrava chiuso da tempo – ma di notevole fattura e sormontato da uno stemma nobiliare di cui, data la distanza, non ero riuscito a distinguere i particolari. Non riuscivo a distinguere nemmeno i particolari del cartello e il fatto che fosse attaccato al portone, deturpando ulteriormente quel che restava delle sue originarie fattezze, mi procurò una sensazione di fastidio; credevo si trattasse di un manifesto pubblicitario. Mi ero accostato, quindi, per vedere meglio.
Non si trattava di pubblicità, era il ringraziamento che i familiari del defunto barone Tortorci esprimevano nei confronti di coloro che avevano partecipato al generale cordoglio per la improvvisa dipartita del compianto nobiluomo. Una dipartita avvenuta quasi dieci mesi prima, ma nessuno si era incaricato di togliere quel manifesto che aveva ormai esaurito il suo compito.
Da vicino, il portone mostrava tutte le ferite del tempo e dell’incuria.
Peccato.
Mentre tornavo sui miei passi, l’uomo si era alzato dalla panchina sulla quale era seduto, avviandosi nella mia direzione.
Nella parte più alta del portone si poteva chiaramente distinguere un blasone che – come ossa calcinate dal sole – mostrava il bianco dello stucco e soltanto poche tracce del suo probabile originario colore, l’azzurro. Due uccelli appollaiati in cima ad un albero si fronteggiavano; in basso lo stemma era attraversato da due file sovrapposte di riquadri e da due fasce. Il tutto era incorniciato da svolazzi intarsiati nel legno che si intrecciavano con quelli più sfumati che, dalla sommità del massiccio portone, si dipartivano in tutte le direzioni.
La panchina era situata proprio di fronte al palazzo, in un piccolo spiazzo, sopraelevato rispetto al piano stradale e recintato con un’inferriata. Sembrava un balcone aperto sulla strada. Attratto dal palazzo non avevo prestato attenzione a quella sorta di curioso palchetto e non mi ero accorto della presenza dell’uomo.
Fece pochi passi e si fermò addossandosi all’inferriata.
Parlò come se avessimo ripreso un colloquio interrotto soltanto per il tempo che mi era stato necessario per osservare da vicino il portone del palazzo, riattraversare la strada e tornare indietro.
<< E’ morto a Parigi l’anno scorso, ma i funerali sono stati tenuti in paese ed è qui che lo hanno sepolto, nella cappella di famiglia. C’era tanta di quella gente che molti non hanno trovato posto alla Matrice.
Mai vista tanta folla. Qualcuno sostiene che il corpo sia stato imbalsamato e c’è da crederci perché dalla morte ai funerali sono passati nove giorni. Nove giorni di caldo. Se lo ricorda il gran caldo dell’estate passata? >>
Mancava tutta la parte iniziale, i consueti preliminari di una qualsiasi occasionale conoscenza, come il saluto, ed inoltre quell’uomo dava risposte a domande che forse avrei anche posto se soltanto avessi aperto bocca, ma – fino a quel momento – non avevo detto una sola parola.
<< Buon giorno! >>
Un vecchio si era affacciato al balcone di una casa a due piani, proprio sopra di noi, interrompendo con il saluto le mie silenziose considerazioni.
Io risposi al saluto, lui no, non sollevò nemmeno il capo.
Il vecchio si guardò intorno, rinchiuse le ante e rientrò in casa.
Parlava senza alcuna inflessione dialettale e senza alcun particolare accento che avrebbe potuto rivelare la sua provenienza. Basso, piuttosto esile, capelli bianchi, grandi occhiali da vista, carnagione chiara, qualche ruga, mostrava non più di sessantacinque anni.
<< Ne ho tagliate di quelle pietre! Granito, marmo, arenaria, porfido. Per quasi quarant’anni non ho fatto altro che tagliare pietre! >> .
Aveva indicato con un cenno del capo il palazzo baronale dai massicci muri di arenaria rossa al lato opposto della strada.
Indossava pantaloni grigio scuro e un giubbotto di pelle nera con numerose tasche, ampio da sembrare almeno una taglia più grande.
<< Come mai non c’è nessuno in giro a quest’ora? >>
<< Sono tutti a pranzo. Qui la gente mangia a mezzogiorno in punto.>>
<< E lei? Lei non va a pranzare? >>
<< Tra un’ora, io ho orari diversi. In America all’una in punto. Mezzora di pausa per il “lunch”, poi riprendevo il lavoro e alle cinque tornavo a casa. Ho lavorato per trent’anni sempre nella stessa cava a Quincy, nel Massachussets e alla fine, quando sono andato in pensione, ero il tagliatore più anziano che avessero mai avuto. >>
Pronunciò il nome di quello Stato con la naturalezza di un anglosassone.
<< Ho lavorato per cinque anni in Germania, poi mi sono trasferito negli Stati Uniti e ci sono rimasto per trent’anni. Io sono un tagliatore, uno scalpellino, un bravo scalpellino e per trent’anni ho tagliato e scolpito pietre per fontanelle, pavimenti, rivestimenti e lapidi. Pietre semplici, ma lavorate con cura, eleganti, perfette. Qualche volta anche finte lapidi, come quelle che molti americani hanno voluto dopo l’omicidio del Presidente Kennedy. Tutte uguali, nome cognome luogo e data di nascita e di morte; cambiava soltanto il carattere della scrittura.
Credo che le tenessero nel salotto di casa o in giardino. Poi la moda è finita e io ho finito di tagliare finte lapidi. >>
<< Dove si trova Quincy? >>
<< A pochi chilometri da Boston, la capitale dello Stato del Massachussets. Una bellissima città. >>
Aveva ripetuto il nome dello Stato con il medesimo perfetto accento di prima. Il tono delle sue parole, però, questa volta mi sembrò diverso, c’era una punta di compiacimento. Provai anche un po’ di vergogna: non sapevo dove si trovasse Quincy, anzi – fino a quel momento – ignoravo persino che esistesse.
<< Undici anni fa ho anche preso la cittadinanza americana. Ho dovuto imparare un po’ di storia americana, portare dei testimoni e giurare fedeltà alla Costituzione degli Stati Uniti con la mano sul cuore e davanti a un giudice della Contea. L’inglese lo conoscevo già abbastanza bene. Mi hanno dato anche il passaporto. >>
Sorrise con aria soddisfatta.
<< Quindi non è più cittadino italiano >>
<< Ho la doppia cittadinanza. Qualcuno dei miei amici a Quincy mi aveva detto che avrei dovuto rinunciare a quella italiana e invece nessuno me lo ha costretto! >>
I suoi occhi erano divenuti acquosi.
<< Lavoro, lavoro e soltanto lavoro. Gli unici svaghi erano una birra con gli amici ogni tanto, una partita a carte all’Associazione e qualche puntata a Boston, il sabato, per comprare il pesce dai pescatori siciliani. >>
Allontanò lo sguardo per qualche attimo.
<< Trent’anni in America e non posso dire di conoscere l’America. Lo sa che sono stato a New York una sola volta? Eppure è a due passi da Boston e ancor meno da Quincy. In trent’anni ho fatto soltanto due viaggi, uno organizzato dall’azienda per la quale lavoravo, nell’Isola di Nantucket, mi ricordo le aragoste e il museo della caccia alle balene. L’altro con due amici italiani compagni di lavoro, in macchina, dalla costa atlantica a quella del Pacifico, dal Massachussets alla California. Lei non ci crederà, ma in sei giorni, tanto è durato il viaggio di andata, non ho visto altro che autostrade, motels, stazioni di servizio, piccoli e polverosi paesini che gli americani chiamano città e paesaggi sconfinati.
Un grande paese l’America, ma forse non sono riuscito a prenderlo per il giusto verso. >>
Si tolse gli occhiali e si asciugò gli occhi acquosi con un fazzoletto.
<< Perché è tornato in Italia? >>
<< Si guardi in torno. Vecchie case cadenti che molti vogliono vendere, ma nessuno ci riesce, due o tre palazzi nobiliari decaduti come i loro proprietari e che non si sa per quanto tempo resteranno ancora in piedi, disoccupazione, un Circolo dei galantuomini che non ha più privilegi da garantire, niente alberghi, niente turismo, qualche bar dove ancora la gente prende mezza granita, mezza birra, mezzo brendy. Mezze porzioni, proprio come quarant’anni fa.
Qui la vista di un forestiero costituisce un diversivo da non perdere.
Quel vecchio che poco fa si è affacciato a salutare probabilmente ci sta osservando attraverso gli scuri della finestra, con l’orecchio teso ad ascoltare. Ma si tratta soltanto di innocente curiosità. Lei sarà oggetto di conversazione per il resto della giornata e forse anche oltre.
Ho lasciato questo posto trentacinque anni fa perché non trovavo lavoro, facevo la fame. Sono emigrato, ho trovato lavoro ma non ho fatto soldi e non mi sono fatto nemmeno una famiglia né una casa in proprietà, però non ho più avuto fame.
Poi le cose sono cambiate. Negli States riuscivo a stento a sopravvivere con la pensione che ricevo. Tutto troppo caro, niente assistenza sanitaria, qui invece non riesco a spenderla tutta, arrivo persino a metterne da parte. Ecco perché sono tornata. >>
La storia finiva lì, non trovavo altro da chiedere a quel personaggio.
Lo salutai con una stretta di mano. Interpretai la vigoria con cui rispose come segno di carattere e le callosità che avvertii nelle sue dita come traccia tangibile del suo vecchio mestiere.
Mi avviai verso le ultime costruzioni del paese: mi restavano ancora da visitare un palazzo del ‘500, una chiesa e i ruderi di un’antichissima fortezza.
<< Sir ! >>
In quel silenzio al quale ero abituato, il suono della sua voce rimbalzò da un muro all’altro delle case. Aveva usato l’inglese. Mi girai.
<< C’è anche un altro motivo che mi ha spinto a tornare. In tanti anni di lontananza non ho mai smesso, nemmeno un solo giorno, di pensare a queste quattro case cadenti e a una mezza granita in cui inzuppare pane con i semi di sesamo ancora caldo di forno. >>
Rimasi a fissarlo per qualche istante. In piedi, sotto la luce del sole del mezzogiorno appena passato, sembrava ancora più basso di statura, forse a causa del gioco di ombre dell’inferriata. Una leggere brezza gli gonfiava il giubbotto di pelle nera facendolo sembrare goffo e ancora più minuto.
Lo salutai nuovamente, con un cenno della mano, e mi allontanai.
di Giacomo Di Blasi
_____
Il racconto “Il tagliatore di pietre” si è classificato al secondo posto della sezione dei racconti del Premio Nazionale di Letteratura e Poesia “Vincenzo Licata – Città di Sciacca”, Edizione 2009, con la seguente motivazione:
Sciacca, 1 Agosto 2009
“Il tagliatore di pietre”.
Un mondo magico, ovattato, nostalgico nel quale l’autore cala il suo personaggio che, carico di fierezza, rimpianto, accettazione, ricorda.
Emerge con pennellate ricche di colore in tutta la sua drammaticità il percorso di una vita dedicata al lavoro, il lavoro per cambiare il mondo, un mondo che non cambia.
Resta solo osservare e rassegnarsi. Magari dialogare con uno sconosciuto per esorcizzare la pena di vivere.
Il lavoro, di buona fattura, tocca le corde della riflessione con linguaggio convincente.
Enzo Puleo
componente della Giuria del Premio
Ott042009