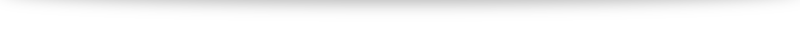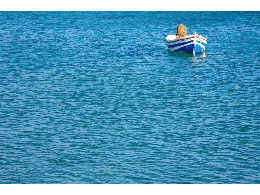“E’ qui?” chiese con una luce di speranza negli occhi.
“E’ qui?” chiese con una luce di speranza negli occhi.
Il dottore soffermò lo sguardo sulla donna che gli stava davanti, sorpreso. Chi cerca? domandò senza aprir bocca. Malgrado ciò, lei se ne stava muta, consunta dall’ansia.
“Cerco il mio bambino” si decise a dire alfine, con un tremito nella voce. “Si chiama Salvatore… ma questo lei non può saperlo: non parla ancora il mio bambino…ha solo un anno.”
Il dottore ebbe un guizzo negli occhi, ma non disse nulla.
“L’hanno ferito il 9 maggio, in via Squarcialupo…Mi hanno detto…sì, a Villa Sofia mi hanno detto che quelli del quartiere San Pietro li hanno portati qui…
Di soprassalto, ogni cosa venne squarciata dall’urlo delle sirene. Il tempo di immergere gli occhi dintorno che si mise a correre alla disperata, e, mentre correva, si gridava dentro: presto! prestooo! Qui, morirò qui! e già le gambe le tremavano.
Una marea di folla vociante si era intanto riversata sulle strade. Ansando a bocca spalancata, Evelina giunse a piazza San Domenico. Di momento in momento, si avvertiva sempre più distinto il rombo degli aerei e la contraerea che sparava contemporaneamente.
In quell’attimo, udì approssimarsi – orribile e crudele – un sibilio e, immediatamente dopo, l’urlo bieco delle bombe che precipitavano di schianto. Esplodevano in una luce bianco, abbagliante. Senza riparo di alcun genere, in mezzo a quegli scoppi implacabili, si sentiva attaccata, accerchiata, schiacciata da una forza immane: spiegabilmente illesa.
Vedeva le case dapprima vacillare come ubriache, e poi accartocciarsi, inginocchiarsi, sbriciolarsi, polverizzarsi, crollare in un turbinio di polvere, legname e calcinacci. Inciampò e quasi cadde sull’ammasso di detriti. Dio mio, supplicava, fa che mio marito e il mio bambino scampino a questo inferno…
Le squadriglie aeree arrivarono a ondate bombardando a tappeto, come se arassero.
Il crepitio era implacabile, disumano, squarciante. Ma lei, con gli occhi fuori dalle orbite, continuava a correre senza fermarsi, come se avesse un cane rabbioso alle calcagna.
Ovunque scene di distruzione e di morte.
Evelina si gettò in via Squarcialupo. Come un miraggio, tra le case, le apparve la sua. Si fermò a fissarla con lunghe occhiate sospettose… era stata bombardata, sì, ma era ancora in piedi!… Aveva il cuore pieno di disperata gioia. La raggiunse con un passo leggero. La porta era aperta. Varcò la soglia. Dentro c’era un silenzio tragico, come di morte. Aggirandosi tra le stanze vuote, si sentì avvolgere da un’improvvisa disperata paura e allora si precipitò fuori gridando: “Dov’è mio figlio?! dov’è mio marito?!”
Al solo pensiero che potesse essere accaduto qualcosa di irreparabile, si sentiva l’anima straziata. Alle sue grida, i vicini si affacciarono alle porte con la faccia mesta. Le si fecero attorno come uno sciame di mosche. Ma nessuno parlava. “Dov’è mio figlio?! dov’è mio marito?!” ripetè mentre si sentiva scivolare nella disperazione.
Finalmente si fece avanti un giovane. Prima di parlare, si passò la lingua sulle labbra. “Io l’ho visto tuo marito mentre si lanciava fuori di casa, tenendo il bambino fra le braccia. Ma, appena sceso dal marciapiede, è caduta una bomba che l’ha colpito in pieno”.
Una ridda di emozioni, ansie, angoscia, disperazione si scatenò dentro di lei. Le parve di stare annegando nel fondo nero di un pozzo. Provava l’impulso di buttarsi a terra e di gridare, di gridare, di gridare. Fino a morire. Si coprì il volto con tutt’è due le mani e scoppiò in un pianto dirotto. Gli altri la osservavano standosene in silenzio, accomunati dallo stesso dolore.
“E Salvatore? dov’è Salvatore?!” gemette all’improvviso, voltandosi a guardare il giovane con occhi spiritati.
“Quando è cessato l’allarme, sono arrivate due camionette dell’UNPA: una ha caricato tuo marito insieme ai… ai morti, e l’altra il bambino assieme ai feriti”.
“E dove lo hanno portato?” annaspò.
“Non lo so”, ammise il giovane con voce sommessa, “sicuramente in qualche ospedale…”
“Si, ma in quale…? Ce ne sono tanti…”
“Chissà… Bisogna informarsi”.
Evelina indietreggiò di un passo, continuando a guardarlo per un lunghissimo instante. Poi, si volse di scatto e, quasi correndo, riprese ad attraversare strade, e piazze, e cortili, in un pullulare di gente smarrita. Vagava di ospedale in ospedale, rincorrendo l’illusione di trovare suo figlio, sempre con la stessa domanda sulle labbra: è qui?
“Guardi in giro… veda se c’è” era la risposta che con impassibile noncuranza le davano medici e infermieri, sopraffatti dalla necessità di prestare soccorso agli innumerevoli feriti. Dattorno c’era un via vai continuo e disperato.
Consumata dall’ansia, ad occhi spalancati, lei, setacciava ogni corsia, da una branda all’altra, scrutando ogni volto. Niente: non c’era… Ma com’era possibile, Dio santo? come poteva, un bambino, dileguarsi senza lasciare traccia? Il solo pensiero di perderlo la spauriva, le toglieva il respiro. Ridatemi mio figlio! supplicava dentro di sé. Ridatemi il mio Salvatureddu. E tutto ciò che mi resta ormai!
Si sentiva umiliata, derubata, espropriata di tutto.
Riprendendo a divagare, il volto del marito si affacciava ai suoi pensieri. Si raccontava che se il bambino era ancora vivo, il merito andava al suo istintivo fargli da scudo col corpo. Povero Vittorio, che sorte amara ha avuto! Nemmeno la consolazione di morire nel suo letto! nemmeno il conforto delle mie lacrime!
Il cielo s’incendiava al sole calante quando tornò a casa.
“Cara signora”, le aveva detto un medico dell’ospedale Gianfilippo Ingrassia (aprendole in faccia gli occhi di giacchio), “in fondo, suo figlio era piccolo…” e poi, senza mutare tono, aveva soggiunto: “… se muore non ci fa niente”.
Cara signora l’aveva chiamata. E aveva avuto pure il coraggio di dire: se muore non ci fa niente. Ma cosa ne sapeva, lui, del suo tormento? della sua disperazione? delle sue braccia vuote? della paura del domani? Suo figlio era piccolo, aveva detto. Va ben, era piccolo. E che vuol dire? Forse che un figlio piccolo non è un figlio? Forse che una goccia piccola non può essere anche infinita?
Sarebbe rimasto smarrito, il medico, a sapere di avere di fronte una donna, povera e per giunta vedova, che aveva scommesso tutto su quel bambino dai riccioli bruni. Che aveva sognato di condividere con lui i giorni, e le speranze, e le gioie, e le delusioni. Che aveva riposto in lui tutto il suo avvenire. Il medico la vedova come una delle tante (noiose e petulanti) che affollavano la sala d’aspetto, e la sua mente. Lei non aveva risposto. Cosa poteva dire a uno che ti parla con tanta indifferenza? Si era mossa. A capo chino. Aveva attraversato il corridoio, stancamente. Ma, appena fuori, aveva sollevato il capo e guardato un punto lontano della strada.
Lei, Evelina Martorana, che superava appena il metro e mezzo d’altezza, di mestiere casalinga, non si sarebbe arresa. Avrebbe continuato a cercare, e a cercare, e dopo avere ritrovato suo figlio, piccola goccia infinita, avrebbe continuato a camminare con la mano nella sua perché lui le avrebbe dato la Forza e il suo Amore.
L’indomani, dipanando ancora questi pensieri, ora intessuti d’angoscia ora di speranza, si diresse verso l’ospedale Cervello. Camminando, covava il suo bambino nella mente. Lo vedeva dovunque: in un fiore, in mezzo a un prato, sopra i muri delle case, dentro un ritaglio d’azzurro. Ma anche lì, sia i medici che gli infermieri dissero: no, non c’è. Come, non c’è? mormorò lei con la delusione negli occhi. No, non c’è: provi altrove.
Non l’avevano nemmeno guardata in faccia. Come se non l’avessero vista. Come se fosse stata un’ombra. Arrancando per interminabili strade, giunse a Villa Sofia che era pomeriggio inoltrato, sempre con la stessa domanda sulle labbra. Finalmente un medico, preso a compassione, disse:” I feriti del rione S. Pietro dovrebbero averli portati alla Rocca. Tenti là, domani” e, osservando le ombre che si allungavano dietro i vetri, concluse:”Adesso è tardi”.
Evelina sentì come riaccendersi una luce nel cuore, flebile, ma sufficiente a farle riprendere la speranza. La pioggia bagnava la sera quando tornò a casa.
L’indomani andò incontro al giorno che era appena chiaro. La speranza dell’alba le dava animo. Avanzava per corso Calatafimi con un solo pensiero: voglio mio figlio.
Strascicava le gambe per la fatica. I chilometri percorsi non si contavano più. Tre giorni di cammino l’avevano sfiancata. Ma non arresa. Lungo la strada, c’erano tante case violate dalla guerra. Ce n’era una, coi muri diroccati e il tetto sfondato, in mezzo a un prato invaso da un delirio di margherite gialle. Nella desolazione che avvolgeva ogni cosa, quei fiori sapevano quasi di miracolo,
Per il breve spazio di un attimo, soffermò lo sguardo su quel prato. Bello sarebbe stato percorrerlo con passi d’aria, tenendo per mano il suo bambino. Bello sarebbe stato…
Da lontano un gallo intonò il suo canto, scuotendola bruscamente dai suoi intricati pensieri.
Arrivò alla Rocca senza più fiato. Imboccò il viale. Un passo… due passi… tre passi… Udiva lo scricchiolio della ghiaia sotto le scarpe. Si accostò all’ingresso, ma, prima d’entrare, si soffermò un momento per sostenersi allo stipite della porta. Ansimava. Inghiottì a vuoto, guardandosi dintorno. Sentì il cuore che bussava e fece un lungo sospiro. D’improvviso, riprese a camminare, tremante. Qualcosa le diceva che lì avrebbe trovato il suo bambino. Era vedova, sì, però le rimaneva lui per cui vivere, per andare avanti. La sua vita avrebbe avuto nuovamente un senso. Provava una felicità quieta. Il domani? Ci avrebbe pensato poi. Non è così che si dice, forse?
“E’ qui il mio bambino?” tornò a chiedere e rimase lì a spiare il medico, lacerata dall’ansia e dalla paura. “E’ riccio, è nero di capelli… ed è bello, il figlio mio. E’ qui?” ripetè con un soffio di voce. Si chiama Salvatureddu comu lu nnomu du Bammineddu, ma questo non lo disse: era la sua maniera di chiamarlo, una cosa che apparteneva solo a loro due.
Il dottore per un attimo incrociò il brillio dei suoi occhi, poi abbassò lo sguardo sull’elenco che teneva in mano …ma quell’attimo, quell’attimo. “sì, il 9 maggio, dal quartiere San Pietro, hanno portato qui un bambino che corrisponde alla sua descrizione” rispose con un mezzo sorriso … ma quell’attimo, quell’attimo era stato capace di colmare una vita intera.
Evelina spalancò la mente al senso di quelle piccole – grandi parole che, emerse dal buoi, adesso fiorivano sulle labbra dell’uomo. Avvertì un’immediata risonanza interiore. Provava una felicità tale che si sentiva tintinnare il cuore. E’ qui! è qui! si ripeteva.
E fu come se la vita si riaccendesse. all’improvviso.
di Tania Fonte
_____
Il racconto “… ma quell’attimo, quell’attimo” si è classificato tra i finalisti della sezione dei racconti del Premio Nazionale di Letteratura e Poesia “Vincenzo Licata – Città di Sciacca”, Edizione 2009.
Gen272010